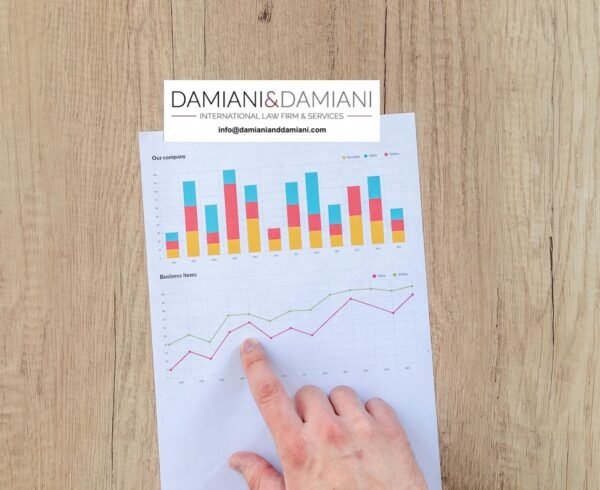Arriva sul tavolo del legislatore italiano uno dei fenomeni già diffusissimi nel resto d’Europa: la sharing economy. Una realtà difficile da concettualizzare, anche detta collaborative economy, che in realtà già esiste da diversi anni, in ambiti settoriali dei più disparati, come l’open source e il car sharing.
La sharing economy non è solo un modo per risparmiare, un modo di fare economia. La sharing economy è un concetto, è un’idea, è un modo di vivere. La sharing economy è un fenomeno sociale. E’ un modo di cooperare per raggiungere un obiettivo insieme. E’ un mezzo per riallocare beni, risorse e servizi e consentirne un uso collettivo e non più individuale, con massimizzazione di profitti, ma anche di risultati. E’ l’accessibilità di tutto a tutti. La sharing economy è il futuro, un futuro in cui si uniscono le risorse alla tecnologia, per rendere fruibile ciò che prima era riservato a pochi, evitando monopoli e sprechi e generando nuove risorse e nuovo guadagno.
La sharing economy è per tutti, è di tutti; ma non è di nessuno. Sì perché alla base della sharing economy c’è una grande rinuncia. La rinuncia ad uno dei diritti più importanti nella storia dell’uomo. Un diritto che ha mosso popoli, economie, Paesi, nazioni: la sharing economy è rinuncia al diritto di proprietà. Quel diritto “esclusivo” che garantisce ad un individuo di essere l’unico. L’unico ad avere il potere su un bene, financo quello di distruggerlo. La sharing economy scardina il concetto di “esclusivo”: utilizzare un bene, un servizio, una risorsa: sì, ma in condivisione con tutti e senza mai acquistarne la proprietà.
Il godimento a scapito del possesso. La sharing economy sconvolge gli schemi, rompe i sistemi attorno ai quali ha sempre girato l’Italia: accedere a tutto non avendo niente. Accantonare l’onerosa proprietà, il concetto de “la roba”, noto ai siciliani, attuato dagli italiani, con la sharing economy ora si può.
Si può grazie ad internet, ovviamente. Internet: il far west del XXI secolo. Il luogo in cui si districano infinite reti, di cui non si trova mai il bandolo della matassa. Lo stesso luogo dove il legislatore arranca, nel tentativo di imbrigliare il regno della libertà assoluta. E’ lì, è su internet che la sharing economy può esistere. E’ lì che la sharing economy trova la sua massima espressione: nelle piattaforme digitali.
E allora nasce il progetto di legge per la “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione (traduzione italiana per: sharing economy n.d.r.)”. Dopo mesi di immobilità, il 2017 porta con sé un forte incremento dei lavori parlamentari sulla nuova proposta di legge sulla sharing economy, e sono tante le novità portate dai nuovi emendamenti.
Il 18 gennaio 2017 il comitato ristretto cui era stata affidata dalle Commissioni Parlamentari la redazione del testo unificato ha reso noto il suddetto, al netto degli emendamenti operati in sede di commissione.
Finalmente, il testo esplicita la definizione di piattaforme digitali, inoltre, il testo unificato definisce gli utenti operatori come consumatori, specificando che sono escluse dall’ambito di operatività le piattaforme digitali di intermediazione “per fornitori di beni o servizi professionisti”. Sebbene il testo unificato non sia particolarmente chiaro sulla questione, sembrerebbero escluse dall’ambito di applicazione della legge le piattaforme digitali che operano attività di intermediazione tra “professionisti”, ossia soggetti che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Insomma il legislatore vuole concentrarsi solo sulla tutela dei consumatori, lasciando fuori i rapporti di sharing economy tra professionisti dalle piattaforme digitali regolate dalla legge.
La definizione data alla sharing economy dal legislatore è la seguente: “l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa di beni, senza trasferimento della proprietà degli stessi, e servizi per il tramite di piattaforme digitali”. Tale definizione, dunque, tiene fuori dall’ambito regolato dal testo unificato tutte quelle piattaforme digitali in cui i beni utilizzati dagli utenti operatori per lo svolgimento della prestazione richiesta sono di loro proprietà.
Ma la vera novità del testo unificato sulla sharing economy, da tempo attesa, è che il legislatore introduce un importante obbligo in capo ai gestori delle piattaforme digitali: il requisito della forma scritta per il contratto concluso fra il gestore e gli utenti operatori/fruitori.
Per ciò che, invece, riguarda gli obblighi relativi ai gestori delle piattaforme digitali, l’intervento più significativo è relativo all’iscrizione da parte degli stessi al Registro elettronico nazionale tenuto presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che diviene facoltativa.
Di conseguenza, l’adozione del Codice di Autoregolamentazione diventa del pari facoltativa.
Contemporaneamente, però, vengono introdotti nuovi obblighi in capo ai gestori di piattaforme digitali, tra cui quello di gestire i pagamenti soltanto per via elettronica e quello di prevedere modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti.
Infine, troviamo nel testo unificato sulla sharing economy un significativo intervento in materia fiscale: l’esenzione IVA per le attività di sharing economy in piattaforma digitale.
Nonostante l’encomiabile intento del legislatore italiano di regolamentare un importante elemento dell’economia moderna, vi sono ancora modifiche al testo normativo sulla sharing economy che lasciano piuttosto perplessi. L’eliminazione dell’obbligo di iscrizione al registro tenuto da AGCM è sicuramente positivo per il diritto del libero esercizio di impresa, nel rispetto della libertà di movimento di beni e servizi, ed è stato auspicato da più parti. Tuttavia, la maggior parte degli interventi finora non risulta chiaro, né risulta chiara la ratio ispiratrice di talune scelte operate dalla commissione parlamentare. Il percorso per la legge definitiva sulle piattaforme digitali della sharing economy è, dunque, ancora lungo e senz’altro le future modifiche che porteranno al testo definitivo saranno piene di sorprese. Cionondimeno, il fatto che detto testo sia approdato finalmente alle commissioni parlamentari è un grosso passo avanti per la normativa e – in definitiva – l’economia italiana. La domanda però rimane: gli italiani sono pronti a rinunciare al diritto di proprietà? Siculi del web, siete pronti a dire addio a “la roba”?